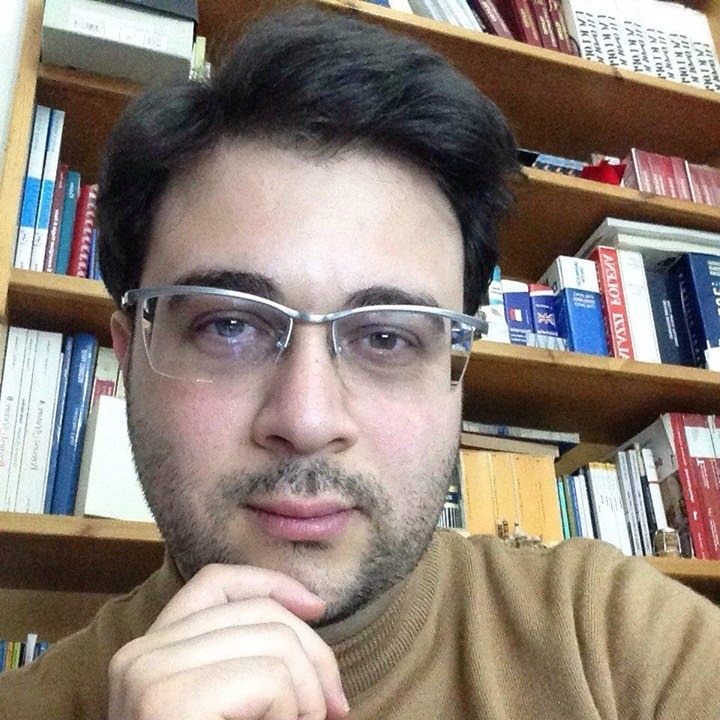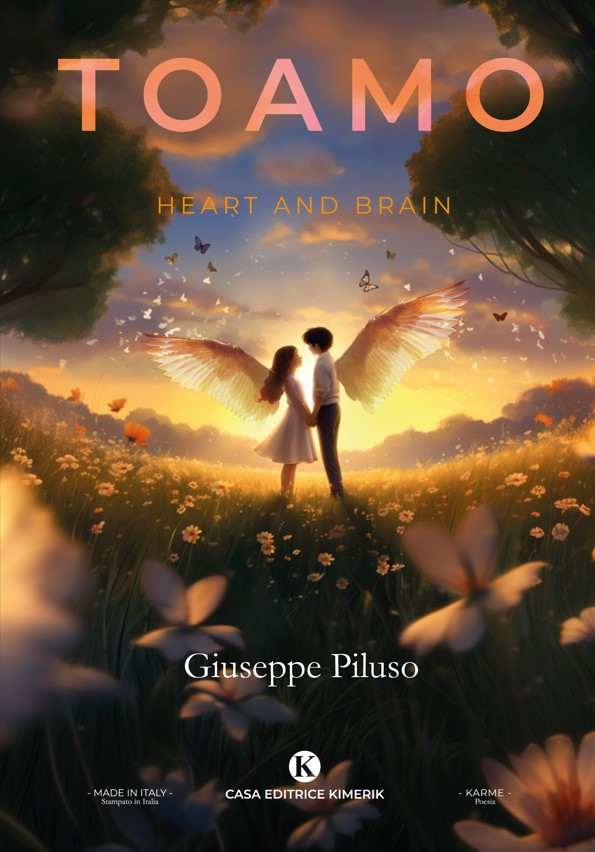FACEBOOK – YOUTUBE – INSTAGRAM – LINKEDIN – ESPERIMENTI
0 – 0 – 0



0 – 0 – 0

0 – 0 – 0
terra, vita e libertà
Colloqui utopici con i filosofi nella trilogia poetica “Toamo” di Giuseppe Piluso
di Cinzia Baldazzi
Se avesse ragione Gottfried Wilhelm von Leibniz e la dottrina della Creazione portasse a concepire il mondo presente come il migliore dei mondi possibili, allora il termine “Toamo”, neologismo coniato da Giuseppe Piluso, costituirebbe il leitmotiv di ogni discorso, di ogni studio e, lo riscontriamo nelle note introduttive a La dama, la terra e il leone, esisterebbe«tra l’essere umano e Dio» e «tra persone di genere differente, ma anche uguale».
Da parte mia, è ovvio, non posso garantire – lo sosteneva il logico-matematico di Lipsia nel tardo Seicento – che il diritto naturale o della terra conduca (lo scrive Alberto Peratoner) «a non ledere alcuno, a dare a ciascuno il suo e a vivere in modo onesto».
Il componimento C’è (Pensiero) – anche in vernacolo rendese – mostra di condividere il rigetto delle aspettative: «E finisco di illudermi… / per non deludermi… / per non avere delusioni… /deglutisco amari bocconi…». Ma prosegue: «Però… / tempo dopo riapro il cassetto, / un palpito nel petto / viver mi fa», fino alla conclusione: «Amore c’è».
Sotto il titolo Toamo – di cui comprenderemo poi il significato – è stata raccolto una trilogia composta da La dama, la terra e il leone (2020), Le due Anime, la Libertà e la Doxa (2022), La Lotta, la Vita e l’Amore (2023). Tutti e tre presentano un nucleo centrale di componimenti poetici corredato da importanti sezioni iconografiche dedicate a fotografie, riproduzioni di quadri e disegni, nonché da scritti in prosa di vario genere: pensieri e considerazioni, invenzioni mitologiche e proposte politiche, racconti e testimonianze.
Nel corso della lettura accadrà che durante il commento io abbia disseminato qua e là enunciati significativi dell’aura etica, storica, filosofica, politica dell’autore, allorché si avvale dei versi o della prosa, collocandoli in punti strategici del contesto ma lasciando solo ad essi l’onere di sopravvivere con altre istanze magari contraddittorie oppure complementari. Non alludo, comunque, a un errore espositivo, tantomeno creativo: quasi nell’antica cultura greca Piluso volesse riproporre il rigoroso rispetto coltivato da Socrate e Platone a riguardo della scoperta personale, imprevedibile e continua, insita nelle risposte degli ascoltatori.
La poetica pilusiana, così come procede nelle tre distinte opere cronologicamente successive, ripropone altrettante fasi esistenziali primarie del Mito della Caverna platonico: lo scrittore scava nella psiche travolta dapprima dal buio della conoscenza parziale (la terra, l’abisso ontologico), quindi la accompagna nel mondo della luce (la libertà, l’opinione), infine ne favorisce l’incontro con l’esistenza (la vita, l’amore) coincidente con le idee.
La dama, la terra e il leone (2020) allinea tre sezioni: La dama, scelta di brani con il sottotitolo “Poesie & Cronaca”; La terra, immagini fotografiche del luogo natìo; Il Leone, che sotto l’espressione “Gli abissi dei miei pensieri” presenta analisi e proposte.
Lungo le numerose tappe della civiltà, in sintonia con Blaise Pascal (vissuto in Francia negli anni di Leibniz), anche in Piluso può prender vita «un rapporto di coppia tossico ove uno dei due individui tradisce, umilia e non protegge il partner, anzi lo lascia a sé stesso esposto alla derisione altrui». In un frangente del genere, il termine “Toamo” non può essere applicato. Come supera tale impasse la sua poësis, al punto di creare i versi di Cuore tra le braccia? «Vicino a me stretta / sembra di stare / su una vetta, / che ho conquistato, / questa volta, non / ho barato, / le mie carte / bene ho giocato!». Presumo lo abbia ottenuto onorando l’importanza del meditare su Dio e sulla dimensione di fede nell’esperienza in specie quotidiana, implicita nel sottotitolo “Poesia & Cronaca” della sezione di apertura.
Dopo la parte centrale inerente alle fotografie, con l’hic et nunc rimasto intatto (suggerirebbe Walter Benjamin) dei paesaggi illustrati, nell’ultima sezione, densa di riflessioni, ritengo interessante evidenziare l’aspetto negativo contemplato nel promuovere una grande alleanza di Stati, ossia nel «rinunciare alla sovranità statale consegnandola a un Ente superiore costituito». Credo sarebbe con noi Piluso nel tentare di “positivizzarla” appellandosi in via utopica al progetto platonico di ricorrere a filosofi-governanti, nel quale – lui stesso rivela – si potrebbe «pensare anche a una forma costituzionale che tenga a cuore e dia più valore alla carta dei diritti umani».
Dove trovare, però, la chiave del successo? Ancora una volta esemplificando Platone, annota Roberto Radice: «Per la precisione, il punto di accordo è l’anima del filosofo considerato come un telescopio puntato sul cosmo delle idee, da dove trae regole e idee da applicare agli eventi contingenti per segnare l’ingresso del Bene nella storia».
In sostanza, Giuseppe Piluso sembra voler indicare la necessità di sviluppare una visione del mondo umano non dissimile da quello naturale – cioè della “terra”, tema dominante del volume – in cui l’idea del Bene filtrerebbe platonicamente attraverso la mediazione dell’ordine geometrico e matematico nella sfera materiale.
* * *
Il secondo volume della trilogia, ovvero Le due Anime, la Libertà e la Doxa (2021), presenta anch’esso una tripartizione. Le due anime è composta da due sotto-sezioni: le poesie de “La farfalla bianca” e i quadri e i disegni (sviluppati dal 2002 al 2020) de “La chimera blu”. Analogamente, La libertà è suddivisa in due parti: “La Libertà di lottare per la vita”, animata da una poesia introduttiva e da un racconto-testimonianza di un trapiantato di fegato, e “La Libertà di lottare per la propria terra”, con istantanee dei luoghi di origine, tra chiese e vicoli. Il terzo blocco, intitolato Doxa, contiene – spiega lo stesso Piluso – «mie opinioni e riflessioni su tutto ciò che concerne lo stato di diritto (il nostro Paese), lo stato d’essere, la sessualità, ma anche la filosofia, la poesia e l’unione tra queste ultime e altro».
Affiorano i due poli rituale-espositivo e personale, in grado – soltanto loro – di indurre il dominio delle forze naturali ad abdicare in favore del regno della libertà: «Il tema centrale di questo secondo libro è quello della libertà (libertà di lottare per la vita e libertà di lottare per la propria terra) […]; le due anime sono l’anima poetica invisibile ma concreta (poiché in essi ci sono frammenti di vita vera e concreta) della farfalla bianca; poi vi è l’anima visibile, ma non concreta».
Nelle pagine dipinte e in quelle scritte, in breve, accogliamo le parole del saggio di Walter Benjamin: «La serietà e il gioco, il rigore e la disinvoltura si mescolano intimamente nell’opera d’arte, seppur secondo differenti gradi». Nell’inquietante altalena di fascino e timori, tipici di una simile attività ludica, leggiamo in Rimango (prima dubbio, ora certezza) questi versi: «Non sono scappato / non me ne sono andato / ed ora abbiamo ricominciato / da te rassicurato / senza perché tutto ho azzerato. / Cattivi pensieri dentro me / tutti che iniziavano con se. / Andiamo avanti mi dissi / e le mie mani strinsi».
All’interno del motivo conduttore di un χρόνος (crònos) ritrovato, il suo segno-segnale, pur azzerato, costringe a cercare la via per raggiungere l’obiettivo: come essere liberi? Giunti a questo punto della ποίησις (pòiesis) di Piluso, siamo consci di quanto, nella scrittura del nostro poeta, la riflessione sulla libertà non derivi dal semplice incontro della volontà di possederla e di pensarla, poiché «nel noi io credo / ed è forte il sentimento / che vedo». Del resto il philosophe francese post-strutturalista Gilles Deleuze ricordava: «I concetti non esistono già fatti in una specie di cielo in cui aspetterebbero che un filosofo li afferri. Bisogna fabbricarli». Ed è esattamente un’operazione simile a condurre Piluso tra una riga e l’altra, fra un’immagine pittorica e la successiva. Nessun significato scaturisce chiaro da sé, il generarsi collima con la genesi dell’atto di pensare nello stesso tempo: «Altro non credo», confida Giuseppe Piluso in Cuorlevante, «e ad alta voce / pensando lo dico, / quando penso… / voglio subito / voglio tutto / nulla di più brutto».
Ed ecco la chimera: indica un point of view della coscienza che non vuole in misura gerarchica fare i conti con la sfera empirica, bensì sostituirla. Da René Descartes a Immanuel Kant, da Edmund Husserl a Karl Jaspers, la coscienza rappresenta il limite rispetto al quale le illusioni della trascendenza si rigenerano: «La verità nelle / briciole era, / tu illusione… / felicità di chimera» [Era]. Sul terreno umano, nel culto del ricordo delle persone amate, lontane o defunte, l’unico rifugio ambìto sembra appartenere al rituale dell’opera d’arte: «Sul letto carte / dove prima c’eri tu» [Blu]. Nemmeno Gilles Deleuze, recuperando un giudizio relativo a Spinoza, trascurava il concetto, sebbene eccezionale, che l’immanenza («la sera» di Piluso) collimasse con il confine della trascendenza assoluta («senza frontiera» oppure «un’altra era!»).
In conclusione, perché il vocabolo δόξα (dòxa, opinione)? Nella sezione ad essa dedicata, posso supporre quanto l’oscurità iniziale sia il frutto di un’immagine dogmatica della ragione, soprattutto causata dall’angoscia totale della mancanza di un concetto godibile e chiaro del desiderio annesso alla politica: lo leggiamo nell’Οἰδίπους (oidìpus, Edipo) di Sofocle, il cui testo è stato eletto come matrice ideologica ai tempi della teoria di Deleuze formulata (con lo psicanalista Felix Guattari) ne L’anti-Edipo nei primi anni Settanta.
Al contrario dell’interpretazione dello psichiatra-psicoanalista Jacques Lacan, la coppia di studiosi era convinta che «il desiderio è un puro e inarrestabile processo produttivo», specifica il professor Fabio Treppiedi, «da pensare in chiave materialistica più come una fabbrica che come un teatro».
In tale ambito, il filosofo Clément Rosset dichiarava: «Il mondo si vede raddoppiato da un altro mondo quale che sia, a favore dell’itinerario seguente: l’oggetto manca del desiderio; dunque il mondo non contiene tutti gli oggetti, ne manca almeno uno, quello del desiderio; dunque esiste un altrove che contiene la chiave del desiderio (di cui il mondo manca)».
Nella trilogia di Giuseppe Piluso, l’aspetto “desiderante” è rappresentato proprio dalla parola “Toamo”, esperimento linguistico o neologismo capace di unire dentro sé le espressioni “Ti amo”, “Ti voglio bene”, “Ti adoro” ma soprattutto “Ti desidero pienamente”. La sintonia è ancora con le parole di Deleuze: «Se il desiderio produce, produce del reale. Se il desiderio è produttore, non può esserlo se non in realtà, e di realtà».
Lo sconforto transita così in direzione della gioia: «Per quanto buio ci possa essere in una notte senza luna e senza stelle», racconta Piluso, «e magari con vento e pioggia battente, questa situazione non è per sempre, la pioggia cesserà, le nubi se ne andranno e si vedranno le stelle e la luna, facendo capolino, sarà presente; e mentre il sole sorgerà, lasciando il posto a quest’ultimo la luna ci sorriderà e sussurrerà ai battiti del cuore: “Domani splenderò solo per voi!!!”».
* * *
Il terzo e più recente contributo alla trilogia “Toamo” è La Lotta, la Vita e l’Amore (2023). Nella parte iniziale, La lotta, il lettore troverà trenta poesie seguite da “Mito, Pensiero & Racconto”, contenente la descrizione di una inedita figura mitologica, alcuni pensieri e una breve prosa narrativa. “La Vita propone fotografie scattate in terra di Calabria (“Lo Stupendo Sud”), elaborazioni grafiche (“Quadri e quadretti d’un fiato”), prove di logica (“Gioco semplice”). L’ultima sezione denominata L’Amore contiene “Giocando con le parole”, giochi linguistici e neologismi, infine una mini-antologia intitolata “Poesie appese”.
In La testa va… solo con te! Giuseppe Piluso confessa: «Massaggiando / gustando / le azioni più belle, / e quando innaffio / contemplo le stelle. / Ma ciò viene dopo / molto dopo un sentire / è l’amore che / non ti fa fuggire». L’instancabile ricerca, qui orientata a identificare le «azioni più belle» dell’onnipresente e onnipotente Toamo, riconduce alla mente la sistematica di Edmund Husserl – caposcuola della Fenomenologia e maestro, tra gli altri, di Martin Heidegger – quando affermava: «Non dalla filosofia, ma dalle cose e dai problemi deve provenire l’impulso alla ricerca». Infatti, prosegue Piluso: «Quel sentimento che tu / tutta sei mia e io / tuo tutto sono, / e il nostro sentimento / è più grande del tuono». Il fondamento fisico-concreto dell’ἔρως (èros) supera nella conoscenza quello mega-naturale del boato sonoro del tuono, se non addirittura astratto, in quanto può produrre in noi immagini fantastiche del creato.
Ancora di più, il filosofo di Prostějov, nella scoperta del microcosmo nella totalità, pur discreditando il pensiero come unica fonte conoscitiva, ribadisce un contesto circostante costituito non solo di “cose” (tavoli, sedie, elettroni, galassie) ma anche di elementi “psichici” dotati della caratteristica di essere “a proposito di” tavoli, sedie, elettroni, galassie. In realtà, nell’ideologia del suo maestro Franz Brentano ho rintracciato un concetto straordinariamente aderente a certi passaggi poetici di Piluso, in particolare alla poesia La testa va… solo con te!: «Ogni fenomeno psichico contiene in sé qualcosa come oggetto», annotava Brentano. «Nella presentazione qualcosa è presentato, nel giudizio qualcosa viene accettato o rifiutato, nell’amore qualcosa viene amato, nel desiderio desiderato».
Allora, come è fatto il mondo, si chiede lo studioso husserliano Pier Alberto Porceddu Cilione, «se esso include, oltre alle cose, anche una dimensione autocosciente che pensa se stessa e il mondo come suo oggetto? E come è fatto il mondo, se la nostra coscienza è “coestesa” a esso?».
Dopo aver sfogliato pagine occupate da fotografie, grafica e quadri di varie fonti ispirative, a loro modo risolutivi del quesito di Husserl, l’autore risponde all’interrogativo nell’alternare l’efficacia di un mito di sua creazione, la dèa Téosy, paladina sia delle lettere sia della φιλοσοφία (filosofìa), a quella del Sole, stella e nume esso stesso nella veste di Ἥλιος (èlios). Ma cos’è il μῦθος (miùthos) nella testimonianza di un grandissimo che di certo non ne fu un simpatizzante? Alludo a Platone il quale, al di là di una propensione sospettosa nei confronti della mitologia – a quell’epoca, pensate – la usò con disinvoltura nel suo sistema, delegando solo agli dèi l’onere di provare certe tesi e di condurre alla ricerca del vero. Un simile arcano di natura mitica, in qualche misura credibile, viene sciolto dalla divinità di Giuseppe Piluso: «Lei non guida, ispira solamente i sui adepti e li lascia liberi di esprimersi e di auto-determinarsi nei pensieri, ma non nelle azioni; per scelta sua demandando ad altri dèi il compito di aiutare gli umani in altre situazioni».
L’apparente incoerenza platonica, a parere di Roberto Radice, si spiega «intendendo il mito nel senso di racconto, cosa che la lingua greca permette, in quanto in essa “mitologia” indica sia l’uno sia l’altro termine. Tuttavia Platone interpreta il primo tipo di mito, quello omerico, come “racconto del falso”, mentre il secondo tipo – quello che lui stesso inventa – è un racconto verisimile». Una scelta stilistica del genere si combina con il cliché adottato nell’intera trilogia, quando Piluso rappresenta la divina Téosy nell’atto di affidare ai «suoi prediletti una coroncina di fuoco che non brucia e consuma, ma dà energia psichica e fisica, quanto basta per produrre».
Concludo evocando un ultimo colloquio utopico dello scrittore con il pensatore da me preferito all’interno del ‘900, ossia Ludwig Wittgenstein. Se fosse con noi, suppongo consiglierebbe al nostro poeta: «Tutto ciò che la filosofia può fare è distruggere idoli. E questo significa non crearne di nuovi». E Piluso, nonostante metafore e allegorie, aforismi e sentenze, di questo inganno non è rimasto prigioniero.
Prof.ssa Cinzia Baldazzi
0 – 0 – 0